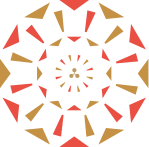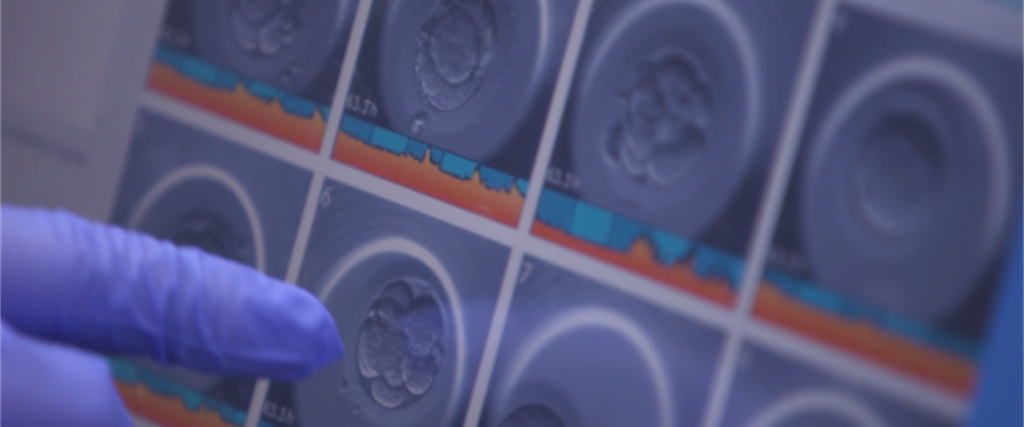Una delle canzoni che ricordo con maggiore forza dalla mia giovinezza è Piccola storia ignobile di Francesco Guccini, dove si racconta con una crudezza graffiante il dramma di una ragazza lasciata sola ad abortire, che sperimenta nella carne e nell’anima il dolore di questo rifiuto alla vita. Una delle pagine emotivamente più dense della mia gioventù è legata a un incidente stradale. Avevo sedici anni e durante un pomeriggio d’estate con gli amici eravamo a fare una scampagnata con i nostri motorini. Uno di noi, mentre tornavamo a casa, bucò una ruota e cascando batté la testa. Ricordo il tempo che sembrava non passare mai davanti alla porta chiusa dell’ospedale fino a quando un medico uscì rincuorandoci: il nostro amico era fuori pericolo. Una delle immagini che mi ritornano alla memoria dalla mia infanzia, infine, è il giorno in cui ci congedammo dalla mia bisnonna: tutta la famiglia era attorno al capezzale e ringraziammo il Signore della vita per il dono amorevole di questa madre, nonna e bisnonna che ci aveva insegnato cosa vuol dire voler bene giorno dopo giorno.
Nascere, la salute, la malattia, la morte: elementi profondamente umani e profondamente connessi al mistero della vita, che la Chiesa guarda e protegge nel suo insegnamento bioetico. Ma se guardiamo oggi questi luoghi antropologicamente densi – esperienze profonde del nostro essere creature nelle mani di un Dio amorevole – troviamo modi molto diversi di vivere gli stessi problemi. Se guardiamo all’inizio della vita dobbiamo riconoscere che il desiderio di avere un figlio ha incontrato ormai da diversi anni la tecnologia con la procreazione artificiale. La tecnologia medica però è uno strumento che non garantisce le stesse percentuali di successo che possiede se applicata ai materiali inerti: la vita con tutte le sue variabili resta imprevedibile.
Alcune start up vogliono usare immagini digitali ad alta risoluzione per “addestrare” la macchina a “capire” e “decidere” sulla qualità degli embrioni. La prassi comune è che dopo l’unione dei gameti si tengono in coltura gli embrioni per cinque giorni, cioè fino a quando si sviluppa una massa di circa cento cellule il cui nome tecnico è blastociste. Solo a questo punto si procede con il trasferimento tubarico dell’embrione. Per farlo i tecnici sono soliti guardare a simmetria e numero delle cellule, un processo molto soggettivo, che si affida all’istinto del personale specializzato. Elpida Fragouli della Reprogenetics, società che è parte di un network globale di laboratori per la fecondazione artificiale, sostiene che l’utilizzo di macchine dotate di sistemi di intelligenza artificiale (AI) renderebbe questa analisi oggettiva, incrementando il successo delle tecniche di fecondazione artificiale. Stando alle parole della Fragouli, questo permetterebbe di stare al passo con i “segni dei tempi” che chiedono alle donne di posticipare la data della gravidanza. Il team della Fragouli sta sviluppando un metodo per identificare gli embrioni da scartare misurando il livello di Dna in quella parte delle cellule – i mitocondri – deputata a magazzino energetico. L’idea è che sotto alcuni “livelli-soglia” la possibilità di impianto non sia favorevole. Secondo i dati raccolti, il metodo sarebbe stato in grado di predire con accuratezza quali embrioni sui 249 trasferiti nelle tube avrebbero fallito nell’impianto, aggiungendo che così non ci sarebbe bisogno di prelevare cellule dall’embrione sottoponendolo a ulteriori rischi. L’Università di Stanford ha sviluppato un modello matematico in grado di predire con una precisione del 90% l’attitudine di un embrione a svilupparsi nello stato di blastociste in forza della sua resistenza e flessibilità alla compressione nel prelievo con una pipetta da laboratorio. Alla Northwestern University si sviluppano modelli matematici basandosi sul rilascio di zinco da parte di un ovulo al momento della fecondazione.
Se la tecnologia e i sistemi di intelligenza artificiale promettono risultati migliori, non possiamo evitare di interrogarci sul significato dell’”oggettivizzazione” indicata per questi metodi. Possiamo affidare a una macchina la selezione di chi è degno di nascere e chi no? Può un sistema statistico decidere quali vite sono degne di vivere e quali no? Non stiamo forse realizzando alcune delle peggiori distopie che la letteratura ha ipotizzato? Se ci spostiamo alla fine della vita le cose non sono differenti. Google ha un team chiamato «Medical Brain» che ha sviluppato un algoritmo per stabilire i rischi legati alle condizioni di salute e le probabilità di morte per ogni utente, sostenendo di raggiungere fino al 95% di certezza nello stabilire se il paziente morirà nel giro di 24 ore da quando è stato ammesso in ospedale. Per farlo ha preso i dati di 216mila casi in 114 mila pazienti utilizzandoli per allenare l’algoritmo. L’approccio di Google non solo consente di avere un’accuratezza superiore rispetto ai metodi predittivi utilizzati oggi ma evita il “lavoro manuale” degli esperti per rendere i dati presentabili. Essendo la diagnosi automatica, gli ingegneri di Google ritengono che si possa risparmiare circa l’80% del tempo che oggi impiegato in diagnosi e prognosi. Il sistema funziona mediante una rete neurale che analizza i documenti e compie previsioni sulle condizioni del paziente nel futuro immediato e prossimo. L’accuratezza dei risultati è così elevata che Google ha già pianificato esperimenti in diversi ospedali per verificare l’affidabilità del sistema e stabilire se potrà divenire un prodotto commerciale.
(di Paolo Benanti)