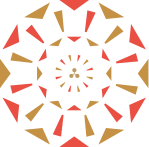DUE PAPATI A CONFRONTO Questi giorni di coronavirus sollecitano l’interrogativo sul nostro essere Chiesa, anche in vista di una ripresa dei lavori del Sinodo (vedi l’Editoriale a pag. 1). Insieme, però, questi giorni sono stati arricchiti dalla memoria viva di san Giovanni Paolo II e del suo lungo pontificato. C’è relazione fra le due cose? O meglio: non c’è contraddizione fra i toni trionfalistici con i quali abbiamo rievocato Giovanni Paolo II («La fierezza ritrovata», Il Settimanale n. 20, pag. 2) e quel senso di umiltà e di povertà, se non di marginalità, che stiamo invece sperimentando in questi mesi, e che sembra essere il tratto distintivo della Chiesa di Francesco (vedi sempre l’Editoriale di questo numero)? Rispondo che no, non c’è contraddizione. Bensì sviluppo nella continuità. Anzi – ecco la tesi che intendiamo illustrare – è anche grazie a Giovanni Paolo II che oggi abbiamo Francesco: infatti solo una Chiesa saldamente riconfermata nella sua identità (Giovanni Paolo II) può lanciarsi in uscita sulle strade del mondo, raccogliendo in modo radicale la sfida conciliare del dialogo (Francesco).
A cura di don ANGELO RIVA
I limiti di papa Wojtyla
Uno storico piuttosto caustico nei confronti di Giovanni Paolo II come G. MICCOLI (In difesa della fede. La Chiesa di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI – Rizzoli 2007) sottolinea come i meriti indubbi del pontificato di Wojtyla – la spallata non violenta data ai regimi comunisti, il no alla guerra e all’antisemitismo, la purificazione della memoria del Giubileo – abbiamo riverberato su di lui un’alea di trionfalismo capace di mettere la sordina ai suoi limiti ed errori. In effetti una rivisitazione critica del pontificato di Wojtyla – pur nel riconoscimento della statura gigantesca di questo Papa santo (cosa che Miccoli erroneamente svaluta e minimizza) – potrebbe evidenziare l’esistenza di almeno due nodi caldi, problematici: (1) la mano pesante contro quegli indirizzi teologici del post-concilio che furono in seguito definiti da Benedetto XVI (al tempo Prefetto del Sant’Uffizio, e poi successore di Wojtyla) come «di rottura» (e non di continuità creativa) con la grande tradizione della Chiesa (cfr. Benedetto XVI, Discorso alla Curia, 22.12.2005); (1bis) di conseguenza, gli attriti con alcune Chiese locali di orientamento prevalentemente progressista (Austria, Olanda, Sud America) circa la nomina di vescovi di orientamento viceversa tradizionale e conservatore; (2) la tensione irrisolta, lungo tutto l’arco del pontificato wojtyliano, fra un’apertura al dialogo davvero senza precedenti (con le culture, con le altre religioni, con i cristiani non cattolici…) e l’immagine di una Chiesa trionfalistica, certissima nelle sue convinzioni dottrinali e veritative, fino al rischio di far sembrare il dialogo stesso una forma di paternalismo («parlo con te, ma so già tutto io») o di gretto proselitismo; (2bis) di conseguenza, la tensione fra un’immagine di Chiesa ritornata «al centro» (secondo l’immagine del nostro Editoriale), simile a quella del passato pre-conciliare, e l’immagine di una Chiesa a servizio dell’uomo («in mezzo»), a imitazione del Maestro. Chiaramente la matrice polacca di Giovanni Paolo tendeva a trattenerlo sul primo modello (il cosiddetto «ecclesiocentrismo»), ma la sua intelligenza, la sua cristologia aperta, e la sua santità fiera ma umile, lo spingevano a oltrepassare questo paradigma.
Il dissenso teologico
Il primo dei due nodi problematici ebbe almeno due chiari epicentri: l’America Latina, con la severa reprimenda della Teologia della Liberazione (fin dalla partecipazione del Papa alla Conferenza dell’episcopato latino-americano di Puebla del 1979); e il mondo cattolico tedesco e anglo-sassone, a proposito di opinioni teologiche molto aperturiste su questioni dottrinali (la democrazia nella Chiesa, il sacerdozio alle donne, il celibato dei preti) e morali (la validità dell’Humanae vitae, e più in generale di tutta la morale sessuale cattolica tradizionale). La «normalizzazione» portata avanti da Giovanni Paolo II, con la collaborazione della Congregazione per la dottrina della fede guidata da Ratzinger, fu indubbiamente veemente, robusta e rigorosa: encicliche papali (pensiamo alla Veritatis splendor sulle questioni morali), istruzioni della Congregazione, censure verso singoli teologi (il tedesco Kueng, il brasiliano Boff, l’americano Curran). E fu accompagnata, come detto, da una speculare politica di nomine episcopali di ortodossia certa. Rilievi critici anche pertinenti possono essere mossi a questa azione «normalizzatrice»: ma non possono tuttavia cambiare la sostanza di un giudizio positivo – anzi, provvidenziale – su di essa. Perché un discernimento critico e un giro di vite erano indubbiamente necessari, nei confronti di indirizzi teologici troppo temerari, spericolati e in discontinuità con la tradizione della fede, in quanto essi rappresentavano un rischio per l’identità della Chiesa e per l’ortodossia della fede. Riassettare una linea di galleggiamento dopo le tempeste del postConcilio fu anzi uno dei meriti storici di Giovanni Paolo II. Per quanto i metodi usati – tanto nel fare le pulci ai teologi troppo creativi, quanto nella nomina di vescovi affidabili – non furono sempre soffici ed esenti da unilateralità.
Il caso della Teologia della Liberazione
Emblematica, al riguardo, fu proprio la vicenda della Teologia della Liberazione latino-americana. I suoi aspetti problematici (sul modo riduttivo di intendere la figura di Gesù, e soprattutto sull’adozione del marxismo come strumento di analisi e di trasformazione della società) esigevano effettivamente un intervento correttivo ed equilibratore. Che ci fu: Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione su alcuni aspetti della teologia della liberazione, 1984. Tale intervento, però, mentre rimetteva in ordine gli accenti e il raccordo con la tradizione, trascurava alcuni fattori rilevanti. Per esempio che la sigla «teologia della liberazione» avrebbe dovuto essere coniugata al plurale, non al singolare, perché diversi, e molto differenti, erano le sue anime interne: da quella spiccatamente marxista-rivoluzionaria, a quella che era più che altro una riflessione pastorale sull’esperienza delle cosiddette comunità ecclesiali di base. Oppure il fatto che assai differente era lo scenario politico dell’America latina rispetto ai paesi del socialismo reale (che Wojtyla naturalmente ben conosceva): mentre gli Stati comunisti dell’Europa orientale erano dichiaratamente avversi alla Chiesa, i diversi «governi di sicurezza nazionale» al potere in Sudamerica (pensiamo tipicamente alla dittatura di Pinochet in Cile) cercavano l’appoggio della Chiesa come riserva morale della nazione, e si presentavano come cattolici, e paladini dei diritti della Chiesa, proprio contro l’espandersi del demone marxista. Questo creava ambiguità, strumentalizzazioni della Chiesa da parte governativa, tentazioni di potere da parte ecclesiastica, e soprattutto il rischio per la Chiesa di ritrovarsi schierata dalla parte dei potenti contro gli oppressi. Sarà la storia a emettere un giudizio più obiettivo sul rapporto fra il papa polacco e la Teologia della Liberazione latino-americana. Dà però da pensare il fatto che l’eredità più recente di quegli anni turbinosi sia stata l’apostasia di massa di molti battezzati cattolici verso le varie «sette» riformate finanziate dagli Stati Uniti: ad oggi, probabilmente, il problema pastorale più serio che attanaglia la Chiesa cattolica latino-americana. Un fatto però appare certo: la Teologia della Liberazione, da quell’aspro passaggio, ne uscì purificata. Confermata nei suoi assunti di base (il popolarismo, la dimensione concreta e pratica dell’evangelizzazione, l’opzione preferenziale per i poveri, l’invettiva profetica contro le ingiustizie e le disuguaglianze sociali), ma insieme restituita al primato assoluto della trascendenza, della fede, della vita spirituale, della preghiera. Che era in fondo l’intendimento principale di Giovanni Paolo II. Jorge Mario Bergoglio rappresenta, da questo punto di vista, uno dei migliori frutti germinati da questa complessa stagione ecclesiale. Lo testimonia l’Evangelii gaudium, letta a partire dall’ultimo capitolo («Evangelizzatori con Spirito»). Per questo, allora, possiamo dire che è anche grazie a Giovanni Paolo II che abbiamo oggi Francesco. E la voce di una Chiesa venuta «dai confini del mondo», depurata dagli ideologismi e restituita al primato dello spirituale, risuona oggi potentemente, per bocca del Santo Padre, come forza di rinnovamento e di conversione pastorale per tutta la Chiesa cattolica.
Dialogo o verità
Rimane poi il secondo punto: Chiesa trionfalistica o Chiesa del dialogo? Chiesa «al centro» o Chiesa «in mezzo»? Su questo aspetto risulta innegabile l’accelerazione impressa da papa Francesco, volta a sciogliere quella tensione che in Giovanni Paolo II rimaneva per lo più latente. Ma conviene parlare di «sviluppo nella continuità», più che di rottura o discontinuità. La «continuità» sta nel dialogo a tutto campo (culturale, ecumenico, interreligioso), di cui Giovanni Paolo II è stato a tutti gli effetti – dopo Paolo VI e sulla scia del Concilio – il principale artefice. Lo «sviluppo» sta nell’assunzione a tutto tondo di un tema peraltro assai caro a Benedetto XVI (ad es. Deus charitas est 10): il dialogo si basa ed è reso possibile dalla verità (Logos), «ma il Logos è al contempo un amante» (Agape). Oggi Francesco sta portando alle estreme conseguenze proprio questa intuizione dei suoi due predecessori: il dialogo è sì testimonianza della verità, ma non senza l’accoglienza radicale dell’altro diverso da me, sul modello dell’ospitalità di Cristo (cfr. A. LIND, L’opzione per il Logos nel pontificato di Francesco, in “La Civiltà Cattolica 4076”, 126-140). Questo elemento radicalmente dialogico/relazionale, che tanto spaventa i cattolici tradizionalisti (che temono lo smantellamento della verità cristiana), non è affatto in contrasto con il tema tipicamente wojtyliano della testimonianza della verità, bensì lo presuppone. E insieme lo depura da ogni possibile residuo di paternalismo o di gretto proselitismo. Facciamo l’esempio del dialogo ecumenico e inter-religioso. Giovanni Paolo II ne fu cultore instancabile, con momenti anche di assoluto spessore storico (l’incontro di Assisi, la richiesta ai fratelli ortodossi di essere aiutato a vivere il primato petrino…). Però i suoi ripetuti richiami alla pienezza della verità (che, in quanto tale, sussiste solo nella Chiesa cattolica) sembravano attribuire un tono paternalistico al dialogo ecumenico o inter-religioso, volgendolo nella direzione del proselitismo, o del «ritorno» dei fratelli separati sotto il tetto di Roma. Francesco supera decisamente questa tensione irrisolta. Con lui l’istanza veritativa cattolica non viene ovviamente dimenticata: per esempio, nessun dubbio sussiste sul fatto che il «primato petrino» sia un elemento irrinunciabile della verità cristiana. Tuttavia il punto è un altro. Si tratta, per Francesco, di non far diventare l’irrinunciabile pretesa veritativa (presente, fra l’altro, in entrambi i soggetti del dialogo) una credenziale di superiorità che fa aggio (di fatto impedendola) sull’accoglienza fraterna del partner del dialogo, rendendolo così arduo (perché impari, paternalistico). Si tratterà allora sì di una pretesa di verità (che nasce dal Logos), ma da ritenersi (da ambo le parti) con molta umiltà: l’umiltà che nasce dall’amore reciproco (Agape). Diversamente, l’irrinunciabile pretesa di verità diventerebbe qualcosa che divide e ferisce. Pur senza escludere, ovviamente, che a volte il dialogo possa anche proseguire nella forma di un cordiale disaccordo fra gli interlocutori. Francesco sta chiamando la Chiesa ad assumere sistematicamente questa postura dialogica, che è l’arte di fare la verità nell’amore. Nella misura in cui la Chiesa saprà farlo, verrà superato ogni inutile – e probabilmente dannoso – trionfalismo. E la Chiesa, aggrappata a Cristo, ritroverà pienamente il suo posto nel mondo dell’uomo. Non più «al centro», ma sicuramente «in mezzo».