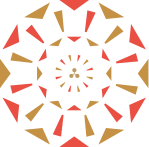UNA PURIFICAZIONE NON RICHIESTA
Per le comunità cristiane – e in modo particolare per i preti – è un’ora di umiltà, di penitenza e di purificazione. Ma una purificazione senza precedenti, che mai avremmo immaginato di dover vivere: la purificazione dell’inazione, dell’immobilismo, del non poter fare niente. Normalmente, al cospetto di una tragedia personale (un lutto) o collettiva (un terremoto, un’alluvione), come Chiesa ci si muoveva di corsa. Accorrere, stare con la gente, non lasciare sole le persone nell’ora della tribolazione. Potendo dispiegare le armi della presenza e del culto. Con la presenza si serravano i ganci dei legami fra le persone, si organizzava la resilienza comunitaria, si sosteneva e si promuoveva la prossimità e la cura reciproca. Un primo modo per elaborare il lutto, rialzarsi e tirare avanti. Il culto predisponeva poi le parole e i gesti della speranza e dell’incoraggiamento. Parole e gesti non certo banalmente consolatori, ma importanti per rimanere nell’agone del dramma, e non sprofondare nella paralisi e nel silenzio. Ma adesso, nei giorni del coronavirus? Quanto a «presenza», zero. Anzi, è diventata virtù l’assenza, il non muoversi, lo stare in casa. Divieto di accesso verso chi sta soffrendo. E anche divieto di sosta. Quanto al «culto», zero. Niente messe, niente veglie comunitarie, niente preghiere pubbliche. Soltanto qualche pur benemerito succedaneo mediatico, come le messe e i rosari in “streaming”. Per il resto, tutti fermi. Bloccati. Una sensazione frustrante, a volte raggelante. Un misto di umiliazione e di inutilità, avvertito quasi come una colpa.
Fine della Chiesa?
In questo vuoto ecclesiale (e presbiterale) si è inserita la profezia laicista di una «fine della Chiesa» (qualche giornale lo ha rilanciato esplicitamente). Una rottamazione per raggiunta obsolescenza, per comprovata inutilità. Anzi, per potenziale dannosità, se, per esempio, qualche parroco un po’ invasato pensasse bene di sfidare le misure di distanziamento in nome della potenza taumaturgica della santa fede. «Servono scienziati, non sacerdoti!», si dice. Di più: sembra quasi di assistere alla sostituzione della vecchia religione del signor parroco con una nuova religiosità tutta laica, razionale, scientifica, desacralizzata. Una religiosità con nuovi riti, nuovi simboli, nuovi linguaggi, rispetto a quella del passato. L’inno nazionale, per esempio, rilanciato a tutto volume da finestre e balconi, prende il posto del suono delle campane. La conferenza stampa della Protezione Civile, alle 18.00 di ogni giorno, al posto della messa feriale. Virologi ed epidemiologi come i nuovi sacerdoti e scribi della legge. Totò Cutugno al posto del Tantum ergo. La mascherina sanitaria, calata sulla bocca, al posto della croce portata al collo. I mantra della resistenza governativa («state a casa») al posto delle litanie della Madonna. Gli hashtag dell’incoraggiamento reciproco (#tutto andrà bene) al posto delle benedizioni. Gli spot dei vip dello spettacolo, che invitano a non uscire, al posto delle prediche. E poi – soprattutto – ecco i medici e gli infermieri: i nuovi santi e i nuovi martiri, a cui tributare (giustamente) la glorificazione della lode e a cui affidarsi con un’invocazione di protezione. Tutto giusto, ovviamente. E anche bello e prezioso: lungi da noi l’idea di polemizzare su queste forme di resistenza civile e di mobilitazione collettiva, che ci hanno tenuto a galla. Ma ecco insieme profilarsi la sensazione di un «game over» per la vecchia religione del signor parroco. Come i titoli di coda di una vecchia pellicola sgualcita. Nanni Moretti sentenzierebbe che «la messa è finita». La Chiesa non serve più, è scoccata l’ora della scienza?
Un rischio letale
Naturalmente no, le cose non stanno affatto così. Anzi, proprio in questi giorni di coronavirus tanti uomini e donne stanno riscoprendo il valore e l’importanza della fede cristiana, come dirò subito dopo. Ma prima vorrei indugiare ancora un attimo a sottolineare un rischio potenzialmente mortale per la Chiesa. E cioè che l’inerzia di questo forzato periodo di inazione (ecclesiale e presbiterale) possa effettivamente ammosciare gli slanci
missionari, affievolire la passione pastorale, depotenziare lo zelo evangelizzatore. Finché sono gli atei e gli agnostici a pensare che il coronavirus possa essere il capolinea dell’antica fede cristiana, in fondo ci sta: fanno il loro mestiere. Ma il rischio è che qualcosa di simile finiscano per pensarlo anche i credenti! Noi diventiamo ciò che facciamo, e non diventiamo ciò che abbiamo smesso di fare. Non è allora che la prolungata e forzata astinenza dalla pratica cristiana finirà per convincere anche noi credenti della sua sostanziale inutilità? Che cioè in fondo si può anche stare più o meno tranquillamente senza messa, senza confessione, senza comunità, senza Chiesa? L’arretramento forzato nello spazio dell’inazione, per lasciare campo agli unici che possono e devono agire (tecnici, medici…), non rischia di essere per noi – oltre che una sentenza di presunta inutilità – una tentazione di disimpegno e di diserzione? Un alibi per la fuga, per il quietismo, per la coltivazione della propria «comfort zone»? Un invito a coltivare il placido orticello dell’autoreferenzialità? A preferire gli ovattati silenzi della canonica all’«odore delle pecore»?
Preghiera e parola
Di nuovo: no, non è così, si tratta di un cattivo pensiero, lasciamolo lì. Anche perché non è affatto vero che questi giorni di coronavirus sono stati – per le comunità cristiane e per i sacerdoti – un tempo di totale inazione. Pur nel blocco di una operatività in presa diretta sul campo, la fantasia e la creatività pastorale si sono date parecchio da fare (qualche volta anche troppo, viste alcune «performance» piuttosto stravaganti…). Abbiamo così scoperto, ai tempi del coronavirus, di avere comunque in serbo almeno due formidabili armi. La prima è la preghiera. Arma ignota e invisibile al mondo, ma di cui abbiamo riscoperto l’importanza e l’efficacia. A cominciare dalla preghiera semplice, che chiede la liberazione dal virus. Per passare poi a quella più consapevole, che chiede la docilità alla volontà del Padre. Per arrivare infine alla preghiera di intercessione, tesa a «bucare» la bolla di solitudine e di isolamento di tanti fratelli ammalati e provati. All’inizio, forse, le nostre liturgie «decapitate» del popolo (o meglio «smembrate», vista la presenza del capo ma non del corpo) le abbiamo vissute con un certo disagio e spaesamento. Poi però, forse, chi ha potuto celebrarle ha sentito crescere dentro di sé come un mandato, una responsabilità: che quello strano Triduo pasquale «sine populo» andasse celebrato non «di meno», ma con ancor più cuore, passione e fervore. Proprio in nome dei tantissimi fedeli impossibilitati a farlo, e che lo avrebbero desiderato ardentemente. In più abbiamo riscoperto una seconda, potentissima arma: la parola. Grazie anche a un’inconsueta alleanza con i nuovi mezzi di comunicazione sociale (anche questa una scoperta positiva…), abbiamo visto la parola della Chiesa mobilitarsi, sfrecciare via etere, entrare nelle case, intrufolarsi negli appartamenti, riunire le famiglie, raggiungere i cuori. Per molti la parola della Chiesa, in questi giorni di isolamento, è stata balsamo di consolazione. S’intende: la parola vera della fede, capace di illuminare la vita, di andare al cuore del suo mistero. Non certo il vacuo chiacchiericcio, o la parola devota, insipida e laterale al dramma. Pensiamo, tipicamente, alle parole del Papa in mondovisione da una piazza San Pietro livida e spettrale. Molti hanno percepito, dentro le case, che la parola della fede non è una fiaba edificante, ma quella spada affilata e tagliente che nei momenti giusti sa sviscerare il midollo dell’esperienza umana. è sembrato per certi versi ripetersi l’esperienza del popolo di Israele al tempo dell’esilio babilonese. Con la deportazione il popolo aveva perso, in un colpo solo, il tempio, la terra e la libertà. Proprio come noi in questi giorni di pandemia: senza tempio, senza parrocchia, senza libertà di muoverci. Ebbene, cosa fece Israele esule a Babilonia? Ce lo ricordano i biblisti: redasse la Bibbia! Raccogliendo insieme tradizioni orali e spezzoni di narrazioni scritte già circolanti. Le scienze bibliche ci dicono che fu proprio nel tempo dell’esilio che Israele, rimasto senza tempio e senza terra, si aggrappò alla Parola di Dio, dando un forte impulso redazionale a quello che noi chiamiamo oggi l’Antico Testamento. La forza della parola nella diaspora delle relazioni negate.
La famiglia
Ma c’è un altro elemento. Nel periodo esilico prese corpo in Israele – sempre perché privo del tempio e della terra – una forma di liturgia familiare che poi il popolo stesso non avrebbe più abbandonato, e che ha resistito ai tempi, sfidando olocausti e persecuzioni, fino ai giorni nostri. Nelle case degli ebrei esuli il padre di famiglia riuniva moglie, figli e parenti, faceva memoria del Dio dei Padri e invitava tutti alla preghiera. Chissà che in questi giorni non sia successo qualcosa di simile anche dentro le nostre famiglie? Non eravamo lì a vederlo, ma ci piace sperarlo. Che quella messa del Papa o del Vescovo, quella video-chiamata del catechista o del capo scout, quel messaggio video o vocale del “don” abbia riunito insieme la famiglia, stipata fra le mura domestiche. E abbia aiutato tutti a pregare insieme. E a riscoprire la fede non come il solito brodino religioso da mandar giù, ma come ascolto di Dio Padre, che mai ci abbandona. Sì, nelle famiglie la parola della Chiesa è arrivata, e spesso di qualità. E là dove c’è stato il riunirsi della famiglia attorno alla preghiera, il compattarsi insieme delle diverse generazioni attorno alla trasmissione dell’unica fede, l’attuarsi di quello che il Concilio chiamava il «sacerdozio battesimale» di tutti i fedeli, forse il coronavirus avrà fatto più buon effetto che non dieci anni di faticosa e impegnativa attuazione del progetto diocesano di iniziazione cristiana. Che proprio nella testimonianza familiare della fede trova uno dei suoi perni strategici.
Salubre profezia
Si narra nella Bibbia (Es 17,8-15) che un giorno il popolo di Israele combatteva nella pianura contro gli Amaleciti, mentre Mosè stava sul monte a pregare. Quando Mosè pregava e innalzava a Dio le sue braccia, Israele vinceva in battaglia. Ma quando, per la stanchezza, reclinava le braccia protese verso il cielo, era Amalek a vincere, e il popolo soccombeva. Al punto che Aronne e Cur pensarono bene di far sedere Mosè su una pietra, e di sorreggergli le braccia stando uno da una parte e uno dall’altra. Alla fine Israele vinse la sua battaglia. Chissà, i giorni del coronavirus potrebbero averci consegnato una sorta di profezia. Una Chiesa costretta, con i
suoi sacerdoti, a star fuori dalla battaglia che infuria negli ospedali. A stare seduta su una pietra (che è Cristo). Seduta, ma non ferma. Protesa nella preghiera di intercessione. Perché in quest’ora difficile sia sostenuta, dalla forza dello Spirito, la testimonianza e la lotta di tanti fedeli battezzati. Quei fedeli battezzati riuniti dalla parola della Chiesa in una semplice liturgia domestica. Quei fedeli battezzati che, come medici e infermieri, combattono la dura battaglia contro il virus con le armi della scienza e della testimonianza cristiana. Presto – ne siamo certi – ritroveremo il tempio, la terra, la liturgia eucaristica, la comunità parrocchiale. Però ci resti dentro questa immagine di Chiesa «amalecita». Potrebbe essere una salubre profezia per i tempi che verranno.
Don Angelo Riva